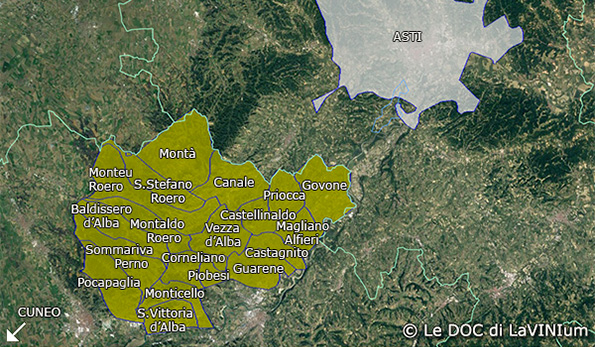Le DOC della Lombardia: Valcalepio

❂ Valcalepio D.O.C.
(D.P.R. 3/8/1976 – G.U. n.308 del 18/11/1976; ultima modifica D.M. 7/3/2014, pubblicato sul Sito ufficiale del Mipaaf, Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP)
► zona di produzione
● in provincia di Bergamo: l’intero territorio amministrativo dei comuni di Carobbio degli Angeli, Cenate Sotto, Credaro, Entratico, Gandosso, Ranica, San Paolo d’Argon, Torre de’ Roveri, Villa di Serio, Villongo e parte di quelli di Adrara San Martino, Adrara San Rocco, Albano Sant’Alessandro, Alzano Lombardo, Bagnatica, Barzana, Bergamo, Bolgare, Brusaparto, Carvico, Castelli Calepio, Cenate Sopra, Chiuduno, Costa Mezzate, Curno, Foresto Sparso, Gorlago, Grumello del Monte, Luzzana, Mapello, Montello, Mozzo, Nembro, Paladina, Palazzago, Ponteranica, Pontida, Predore, Sarnico, Scanzorosciate, Seriate, Sorisole, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Telgate, Torre Boldone, Trescore Baineario, Valbrembo, Viadanica, Villa d’Adda, Villa d’Almè e Zandobbio;
► base ampelografica
● bianco: 55-80% pinot bianco e chardonnay, 20-45% pinot grigio;
● rosso, riserva: 40%-75% merlot, 25-60% cabernet sauvignon;
● rosso passito: moscato di Scanzo e/o moscato;
► norme per la viticoltura
● le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC “Valcalepio” devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto considerati idonei i terreni pedecollinari e collinari di buona esposizione, di natura preminentemente silicio – argillosa.
Sono esclusi i terreni esposti a nord, i fondo valle, quelli umidi, nonché quelli a quote superiori ai 500 metri s.l.m. per le uve merlot e cabernet sauvignon e ai metri 600 s.l.m. per le uve chardonnay, pinot bianco e pinot grigio;
● la resa massima di uva per ettaro ammessa e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 10 t/Ha e 11,00% vol. per il Rosso (12,00% vol. per la tipologia Riserva), 9 t/Ha e 11,00% vol. per il Bianco, 6,5 t/Ha e 11,5% vol. per il Moscato Passito;
● ai fini della vinificazione le uve destinate al Moscato Passito devono essere sottoposte ad appassimento in pianta o dopo la raccolta, con sistemi tradizionali in ambienti adatti. Il periodo di appassimento delle uve non può essere inferiore a 21 giorni e, comunque, anche oltre tale limite, il periodo deve essere protratto sino ad assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 17%;
► norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione e invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nel territorio amministrativo dei comuni anche se solo parzialmente compresi nella zona di produzione delle uve;
● il vino “Valcalepio” Rosso, prima dell’immissione al consumo, deve subire un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno un anno a decorrere dal 1° novembre successivo alla vendemmia, con una permanenza in fusti di legno di almeno 3 mesi;
● il vino “Valcalepio” Rosso con almeno 3 anni di invecchiamento, di cui almeno 1 in botti di rovere, può portare in etichetta la menzione aggiuntiva “Riserva“. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre successivo alla vendemmia;
● il vino “Valcalepio” Moscato Passito non può essere immesso al consumo prima del 12 maggio del secondo anno successivo a quello della vendemmia;
► norme per l’etichettatura e il confezionamento
● nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata “Valcalepio” deve sempre figurare l’annata di produzione delle uve;
● i contenitori di capacità non superiore a litri 5,000 contenenti i vini a DOC “Valcalepio”, devono essere, per quanto riguarda l’abbigliamento, consoni ai tradizionali caratteri dei vini di pregio, pertanto, dovranno essere di vetro, chiusi con tappo di sughero e le bottiglie dovranno essere di tipo bordolese o borgognona per il vino rosso e di tipo bordolese o renana per il vino bianco.
Tali disposizioni non si applicano, tuttavia, per capacità non superiori ai 0,250 litri.
Per il tipo Moscato passito sono obbligatorie bottiglie di vetro scuro di capacità non superiore ai 0,750 litri.;
► legame con l’ambiente geografico
● A) Informazioni sulla zona geografica
◉ Fattori naturali rilevanti per il legame
La zona geografica viene delimitata a nord dalle Orobie, a est dal lago d’Iseo e a ovest dal monte Canto e comprende un territorio collinare.
Le principali formazioni geologiche presenti nella zona collinare Bergamasca sono il Selcifero Lombardo, la Maiolica di Bruntino, il Sass del Luna tipico (o Pietra di Luna) e il Sass de Luna calcareo, le torbiditi sottili, le Peliti nere superiori, le Peliti rosse, Flish di Pontida, Arenaria di Sarnico, Pietra di Credaro, Flish di bergamo, Frangipan e terreni alluvionali.
La genesi delle rocce madri delle colline bergamasche avviene nel periodo Cretacico dell’era Mesozioica; dalle rocce madri anno avuto origine i terreni che sono prevalentemente di tipo eluviale sono quindi terreni rimasti sulla roccia da cui provengono e a questa restano fortemente legati in termini di ripartizione minerale; fanno eccezione alcune zone sulle sponde dell’Oglio e nella zona di Chiuduno di tipo alluvionale.
In linea generale è possibile affermare che nell’area collinare a nord-ovest della città di Bergamo prevalgano terreni di tipo scisto-argilloso, mentre lungo la fascia collinare ad oriente fino al lago di Iseo si susseguono diverse formazioni con prevalenti caratteristiche argillo-calcaree.
L’area Bergamasca presenta tre aree climatiche principali, Collina occidentale, Collina orientale e area di Trescore Balneario (valle).
In esame vengono presi tre parametri quali la radiazione solare, la temperatura e la piovosità o precipitazione meteorica.
In relazione alle temperature e alle radiazioni solari è possibile rilevare come la costante termica in relazione alla fase fenologica della vite Le aree occidentali e quelle di valle presentano costanti termiche inferiori a quella orientale, si va quindi dai 3470 gradi dell’area occidentale e valli ai 3570 dell’area a oriente.
In merito alle precipitazioni le medie annuali si attestavano attorno ai 1100-1200 mm annui fino alla fine degli anni 90. Una riduzione significativa della piovosità si è registrata a partire dal 2003.
Gli scarti annuali rispetto alla media in relazione alle aree geografiche risultano essere contenuti, ma non irrilevanti e si aggirano tra i 200 e i 350 mm.
◉ Fattori umani rilevanti per il legame
La Valle Calepio
“Giace in Orobia una valletta amena,
ove il respiro del Sebino aleggia;
dell’Oglio ondoso la recente vena
il sen ne lambe, rapida serpeggia
e qual fanciullo, cui pietosa cura
strappò al buio di lunga prigioni,a
esulta e fugge via per la pianura
del lago la claustral malinconia.
Su pei clivi sorridono i vigneti,
e in alto sorge, tra suberba e mesta,
di cerri e querce e d’orgogliosi abeti
la corona feudal della foresta. […]”
Ondei, D., 1924
Riportiamo a seguito alcune citazioni di testi antichi:
“Bergamo, dal punto di vista agricolo, era una città produttrice di vino. Quasi quattro quinti delle superfici trattate fino alla fine del XI secolo erano vigneti. […] Anche nei dintorni immediati della città, nel suburbium, c’erano più vigneti che nella media: quasi un terzo della campagna serviva alla produzione del vino.”
Janut, J., Bergamo 568-1098
Dallo stesso testo si evince la maggior quotazione dei terreni coltivati a vite (vinea) rispetto a quelli destinati ad altre colture (campus):
~~Anni~~~~~~Vinea~~~Campus
1976-1000~~~~~7,2~~~~~3,6
1001-1025~~~~~7,9~~~~~3,8
1026-1050~~~~13,2~~~~~7,4
1051-1075~~~~22,4~~~~~5,3
“Altro monte non hai più a te gradito, Bacco lascivo”
Del Brolo, M. Liber Pergaminus, 1110-1112
“Il territorio è molto fertile, e produce eccellentissimi vini […] Sansovino, F., Ritratto delle più nobili et famose città d’Italia, 1575
“[…] in fatto di qualità i suoi vini non cedevano a nessuno delle terre vicine. Molto vitate eran le valli del Brembo e del Serio, produttrici di ottimi vini neri e bianchi ‘che entro l’anno son maturi, e si mantengono sinceri fino al decimo”.
Bacci, A., Storia dei Vini d’Italia, 1596
“[…] Abbonda il territorio di vini ottimi, castagne, carni, formaggi, butirri …”.
Bisaccioni, M., Relationi et descrittioni universali et particolari del mondo, 1664
“La riva destra del Lago d’Iseo, cominciando da Lovere ha un’attività economica particolare che, dall’industria siderurgica di Castro, si estende al prodotto degli oliveti, della vite e della pesca. Ed è, si può dire, da Sarnico, dove il lago finisce, che si apre la Val Calepio, la quale più propriamente si deve chiamare una riviera sulla destra dell’Oglio, operosa e ferace. Altrettanto deve ripetersi per la Valle San Martino, la quale pure è del tutto aperta e lambita dall’Adda per lungo tratto, da Villa d’Adda a Vercurago e dà agli abitanti prodotti della riviera e specialmente il vino”.
Belotti,B., La storia di Bergamo e dei Bergamaschi
Il Quinzani riporta poi come molte carte di vendita, stipulate in epoche assai remote, accennano a vinee e terre vitate, dimostrando come allora si producesse vino e come questi fosse usato quale forma di pagamento.
“[…] Nel 1187 per ordine della corte di Roma, risulta che donando la corte di Almenno al Vescovo di Bergamo, Attone aveva posto condizione che il Vescovo ogni anno dopo la Pasqua fosse tenuto a dare ai canonici di S. Alessandro quattro castrati, vino, pane, farina e uova per far ravioli […]”
Ronchetti, G., Memorie
“[…] Prima che il gelso ed il granoturco penetrassero nella Bergamasca, tanto si coltivava la vite da aversene vino il triplo del bisogno; nel 1610 ne mandava fuori tanto da poter in Isvizzera cambiarlo con quantità di bestie cornute e di cavalli, e a San Marco e a Morengo nel 1525, su 2300 pertiche arative, 6580 piedi di vite maritavansi a 5244 olivi. Il soverchio del vino cambiavasi a Milano e Cremona coi grani, di cui tanto scarseggiavano allora le valli”.
Cantù, I., Bergamo e il suo territorio, 1859
“Robbe che si mandano fuori del paese et per le quali entra denaro forestiero:
Panni bassi, p. 20.000 a 20 = 400.000
Panni alti, p. 8.000 a 50 = 400.000
Ferrarezza = 150.000
Vino, quanto può estraher = 90.000
Sera non lavorata = 60.000”
Note conservate nella Civica Biblioteca di Bergamo e inerenti il calcolo delle esportazioni di Bergamo agli inizi del 1600 (valori espressi in ducati).
“In provincia di Bergamo si producono 155.100 some di vino”
Notizie Statistiche del dipartimento del Serio, 1815 (la soma corrisponde a circa 40 litri, la produzione ammontava quindi a circa 6.200.000 litri, parti ad oltre 20 litri procapite, essendo la popolazione in quell’anno di 304.876 unità).
Sempre il Marengoni sostiene che ‘il vino risulta dal matrimonio tra ambiente e capacità umana: la collina bergamasca e il suo viticoltore non potevano quindi che generare vini, quali il Valcalepio e il Moscato di Scanzo.”
Altre testimonianze dell’antichità della viticoltura in bergamasca ci vengono dall’epoca latina: alcuni storici riportano la notizia dell’impianto di viti in quel di Scanzo da parte dei militi romani.
Inoltre, per i Romani la cultura della vite a Bergamo diventò così importante che fu dedicato un tempio a Bacco nell’antico Borgo di San Lorenzo.
Plinio racconta che in questo territorio la coltivazione della vite era molto sviluppata, soprattutto nei luoghi più appropriati, cioè nella collina.
Quando poi nel 569 i Longobardi invasero la città, la vite, rimasta senza il vignaioli, costretto a una precaria esistenza e soggiogato a lavorare per padroni per nulla avveduti, ebbe un notevole tracollo sotto il profilo della diffusione e della produttività e si rifugiò nelle proprietà ecclesiastiche.
Ma anche nei secoli bui la gente bergamasca non smise mai di amare il suo vino, tanto che il primo atto ufficiale che attesta l’importanza economica del vigneto è proprio un rogito del 750 con il qual viene ceduta una vigna sotto le mura della città.
Risalgono al 1000-1100 d.C. alcune carte di permuta e di vendita di terre vitate.
A testimonianza dell’attenzione prestata dal potere pubblico al vino, nel 1243 Bergamo ordina i piantare le viti lungo la strada che va a Seriate e nel 1266 viene emanato lo statuto di Vertova che impone che “chi tiene a fitto tre pertiche di terreno comunale del Grumelli e nei Zereti vi pianti vigna”.
Del modo dei bergamaschi di allevare le viti si occupa nel ‘300 Pier dè Crescenzi nel suo Opus Ruralium Commodorum.
Indizio del valore dato al vino dai bergamaschi è la diatriba tra Guelfi e Ghibellini riguardo la quantità di carri (98 per i Ghibellini e 60 secondo i Guelfi ) rubati durante il saccheggio delle case dei Ghibellini di Scanzo da parte dei Guelfi; in data 27 febbraio 1398 della questione si occupa il cronista Castello Castelli nel suo Chronicon Bergomense Guelpho-Ghibelllinum: ab anno 1378 usque ad annum 1407.
Durante le guerra per la giurisdizione del territorio della Valcalepio tra Visconti e la Serenissima Republlica di Venezia numerosi furono i saccheggi e le rovine che i valligiani dovettero subire. Una testimonianza si riferisce al 1428 e a ciò che avvenne in Valcalepio dopo che il Carmagnola ebbe abbandonato la Val di Calepio:
“I cittadini e gli abitanti dei seguenti comuni di Calepio, Credaro, Villongo e Adrara, per la fede che sempre mantennero alla Repubblica Veneta, dopo che si assoggettarono distogliendosi dal Visconte, furono per comandamento parte feriti, parte presi, parte posti in rovina, tutti crudelmente perseguitati e malmenati, Le loro fortezze, le torri, le case, le abitazioni svaligiate, distrutte, ispianate fin dai fondamenti i loro mobili rubati, le viti e gli alberi delle loro possessioni tagliati, estirpati […]”
Nel 1569 il bresciano Agostino Gallo parla della eccellente tecnica usata nel trattare le viti, nel capitolo “Quanto bene piantano le viti i Bergamaschi” del suo libro Le venti giornate dell’agricoltura e dei piaceri della villa.
Nella Relazione dell’anno 1595 sulla città di Bergamo e sul suo territorio si legge:
“La Valle Calepio comincia da una parte cioè da Levante a Parzanica […] e continuando sulla riviera pur sul lago si trova Tavernola […] seguendo poi per la riviera di essa si trova la terra di Predore […] successivamente poi venendo per l’istessa riviera del lago […] si trova Sarnico […] di poi partendosi si vien nel loco di Fosio contrada del Comun di Vico Londo et ivi ha dine il lago de Iseo […].
La Valle è lontana da Bergamo milia 12 et da confini alieni dello Stato di Milano verso Antegnate di Cremonese milia 17 in circa. Raccoglie per sei mesi l’anno de grani, ma de vini far per uso et d’avvantaggio. […]”
Nel 1614 Alvise Rizzi stila un elenco dei benefici ecclesiastici del priorato di Pontida e riporta che “[…] i monaci accorparono le proprietà frazionate e disperse plasmando le coste dominate dal sole con vigneti capaci di dare vino potente e buonissimo. Per affinarlo conservarlo hanno costruito una cantina con botti cerchiate in ferro di sei carri l’una e si preparavano a costruirne un’altra per accogliere il nettare derivante dai nuovi vigneti che stavano per entrare in produzione”. La relazione conferma il fatto che dal 1400 a tutto il 1600 la provincia di Bergamo produceva molto più vino del suo fabbisogno, circa tre volte tanto e che il sovrappiù veniva collocato sul facoltoso mercato milanese.
L’inverno del 1709 si rivelò decisamente rigido come riporta questa testimonianza:
“in Valle Calepio venne tanta neve che arrivava sino ai circoli delle viti, cioè alta circa quattro piedi e mezzo, altezza terribile per i nostri paesi, e poi si rasserenò restando la calinge a terra con freddo tanto orribile che mai da secoli non fu udito il simile, che fece seccar tutte le viti, gli olivi e i fichi […].
Dal 1719 per dodici anni successivi fu tanta l’abbondanza dei vivere e delle altre cose necessarie che il frumento stette sempre tra le 18 e le 16 lire al sacco, il vino migliore dalle 8 alle 12 e l’uva dagli scudi 4 agli 8 al carro”.
A partire dal 1700, con l’espansione dell’allevamento dei bachi da seta e della coltivazione dei gelsi, che in pianura sostituirono la vite, la produzione diminuì fino al punto che i Bergamaschi, all’inizio dell’800 furono costretti ad importare vino da altre regioni. A tale proposito Rosa riferisce che ‘nel 1780 non solo [Bergamo] non ne mandò fuori, ma ne introdusse 5000 brente, ovvero 3554 ettolitri, che nel 1840 salirono a 5400 brente od ettolitri 38.172″.
Nel 1820, Giovanni Maironi da Ponte descrive in questo modo la Valcalepio nel suo Dizionario Odeporico:
“La Valle Calepio, così detta dal villaggio, che porta questo nome e che ne fu un tempo la capitale […] si può dir certamente una delle più felici ed amene della provincia.
[…] Il resto della valle è sparso di amene collinette e di bei piani fertili di biade, di gelsi e di vini, i quali, e segnatamente quelli, che si hanno dai suoi ronchi per la loro salubrità e delicatezza sono i migliori e i più pregiati della provincia. Onde il Muzio ebbe a preferire questa valle agli ameni vigneti di Alcino CALEPIO VINI BONITAS ET COPIA NOMEN INDIDIT, ALCINOI NON ITA TERRA FERAX.
[…] Sì fortunata combinazione ha fatto che quivi sempre fiorisce l’agricoltura, e specialmente la coltivazione delle vigne.”
Continua poi il Maironi:
“[…] Credaro piccolo villaggio della Valle Calepio appartenente al distretto e alla pretura di Sarnico […] resta immediatamente sulla strada provinciale, in un territorio fertile segnatamente di vini, che vi riescono molto squisiti e ricercati. […] Credaro è abitato da cinquecento e più perone, la massima parte agricoltori e vignaioli”.
Con l’arrivo della peronospora e dell’oidio e la comparsa della filossera nel 1886, i vigneti subirono gravi perdite ma i bergamaschi in breve tempo reimpiantarono vastissime superfici tanto che già nel 1912 la superficie investita in viti superava quella di un tempo e continuò ad aumentare sino al 1940, all’inizio cioè della Seconda Guerra Mondiale.
Sul Diario-Guida di Bergamo 1923-1924 si legge:
“Credaro, mandamento di Sarnico, circondario di Bergamo, situato allo sbocco della Valle Calepio.
Ha pittoreschi dintorni cosparsi di ville e cascinali. Suolo fertilissimo di vini squisiti […]”.
Gabriele Carrara descrive gli abitanti della Valcalepio come “gente dura alle avversità, come gli ulivi del vento, e pur generosa come i suoi vigneti”.
Dal 1950 la Camera di Commercio si rese promotrice di una vasta innovazione in viticoltura chiamando a consiglio anche illustri personaggi come il viticolo Italo Cosmo e si decise di modificare la base ampelografia, incentivando l’impianto di Merlot, Barbera, Incrocio Terzi, Marzemino gentile e Schiava grossa. Curati i vigneti, non rimaneva che pensare al vino: si istituirono così due cantine sociali, una a Pontida – la Val san Martino – che iniziò a funzionare nel 1959, l’altra a S. Paolo d’Argon – la Bergamasca – che iniziò a funzionare nel 1960.
Sull’Eco di Bergamo del 4 novembre 1950 si legge:
“[…] nello spasimo contorto degli olivi svenati dai secoli, geme ancora, viceversa, lungo i dolci declivi dei vigneti, il singhiozzo strozzato di antichi drammi soffocati tra le mura dei fortilizi o affogati nell’Oglio o nelle acque del Sebino […]. Ma anche il visitatore sprovveduto, dall’altro del colle di Montecchio, il linguaggio di questi resti, filtrato dalla rete fittissima dei filari di vite educata a modello per i moderni vignaioli, ha pure una sua suggestiva parola da dire”.
Luciano Malachini in Aspetti geo-morfologici della Val Calepio sostiene che:
“Un buon bergamasco, cui si chiedesse di caratterizzare la Val Calepio, penserebbe certamente ai vini che vi si producono in copia, ed infatti le pendici delle colline sono coperte da un allegro pergolato di lussureggianti vigneti i quali, se sono meno celebri di quelli di altre zone, che si seppero meglio organizzare commercialmente, non sono però da meno nella bontà del prodotto”.
Della storia della Viticoltura Bergamasca si è occupato anche il dottor Marengoni Bruno, tra gli altri in un saggio così intitolato nel sopraccitato testo del Quinzani:
“[…] Molte viticolture raggiungono quella bergamasca per antichità di origine. Parecchie la superano per raccolto. Ben poche invece possono vantarne una così pronunciata evoluzione qualitativa attraverso i tempi.
[…] Alla fine del secolo scorso la vite alligna anche in pianura, di solito tra i gelsi, associata a cereali e foraggi. Il livello economico generale, di pura sussistenza, e le difficoltà nei trasporti, impongono alla famiglia contadina ed alla collettività, la massima autarchia, ponendo il seconda linea la qualità del prodotto.
[…] L’importazione dall’America della peronospora e dell’oidio, parassiti della vite pericolosi specie in ambiente umido, rende questa coltura in piano assai impegnativa. La comparsa poi di un terzo parassita, la filossera, il migliorato tenore generale di vita, con il conseguente allentamento del regime autarchico e l’esigenza di appezzamenti più ampi idonei alla meccanizzazione decretano la graduale scomparsa della viticoltura in piano. Questa perciò si ritira in collina, ed anche qui, solo sui pendii meglio esposti, in quanto gli altri vengono lasciati al bosco.
[…] Si verifica così il primo presupposto per una viticoltura di qualità: la vocazione naturale dell’ambiente. Il secondo passo determinante per una migliore qualificazione viene compiuto negli anni cinquanta, quando si affrontano tre problemi:
– la scelta, tra una miriade eterogenea, delle uve più idonee;
– la difesa dalla grandine con apposite reti;
– l’adozione di nuove forme di allevamento e di nuove sistemazioni del terreno meglio atte alla meccanizzazione.
[…] viene effettuata una prima scelta fondamentale, escludendo i vitigni troppo tardivi e adottando gli altri, più idonei ai vini abbastanza pronti […] ecco perché tra i rossi emergono il Merlot e il Cabernet Sauvignon […] mentre per i bianchi s’impongono soprattutto i Pinots. Si verifica così un secondo presupposto, fondamentale per i vini di classe: la nobiltà del vitigno”.
Delle zone di produzione della vite, dei vitigni coltivati e dei tipi di vino prodotti trattano anche Compagnoni e Marengoni in Vini Bergamaschi di Qualità e percorsi di degustazione:
“[…] Un tempo la viticoltura era distribuita in tutta la fascia collinare e anche nella media e alta pianura, nonché nella pianura dell’Isola. Mentre in collina la vite è sempre stata in coltura principale, in pianura la prevalenza dei vigneti era in coltura secondaria: in questa zona la vite veniva allevata lungo i filari di olmi o di altre essenze legnose.
In seguito, con l’estirpazione dei filari di piante legnose e con il progredire della meccanizzazione aziendale, tale coltura si è andata via via riducendo, tanto che attualmente interessa esclusivamente la fascia collinare, dove trova il suo ambiente ideale.
Più esattamente ritroviamo queste coltura nella zona collinare vera e propria, che si estende per una settantina di chilometri dal fiume Adda al lago di Iseo e anche in zone considerate montane dalla statistica ufficiale, me che presentano caratteristiche ambientali proprie delle colline e precisamente: la valle Cavallina, la bassa Valle Camonica da Lovere a Rogno, la sponda occidentale del lago d’Iseom l’imbocco della valle Seriana e della valle Brembana.”
– le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini Valcalepio devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere quelli tradizionalmente usati e comunque non atti a modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
Le pratiche relative all’elaborazione dei vini, Nella vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata Valcalepio sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
● B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico
I vini a DOC Valcalepio, in virtù delle differenti tipologie di prodotto e dei differenti vitigni che li compongono, presentano al consumo, caratteristiche organolettiche specifiche, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.
● C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b)
Le caratteristiche del terreno, il clima e le tradizionali pratiche agronomiche ed enologiche del territorio bergamasco conferiscono ai vini delle peculiarità particolari.
Caratteristiche qualitative ed organolettiche delle tipologie di prodotti a DOC attribuibili all’ambiente geografico, comprensivo dei fattori umani, hanno inciso sull’intero processo di produzione. Le tipologie di vino dal punto di vista analitico ed organolettico presentano delle caratteristiche intrinseche dei vitigni da cui sono costituite, derivate dall’ambiente e dal clima nel quale essi vengono coltivati.